Perché sono importanti i sogni durante la terapia psicologica
- Daniele Russo
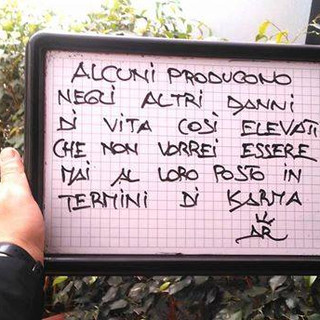
- Sep 27, 2025
- 16 min read

Il sogno come soglia dell’inconscio
Il sogno non è un frammento casuale della notte, né un ornamento poetico della psiche. È il linguaggio muto dell’inconscio che, come scriveva Freud, “non conosce il tempo né la negazione”. È il luogo dove la psiche si concede di parlare senza censura, là dove il pensiero razionale abdica e prende forma la materia incandescente del desiderio e dell’angoscia.
Nella terapia psicologica, il sogno diventa un documento clinico vivo: porta in superficie il conflitto, l’emozione, la memoria e il fantasma. Non è mai neutro, mai innocuo. Quando un paziente racconta un sogno, consegna al terapeuta non un enigma, ma una traccia di verità, che attende di essere ascoltata nel giusto contesto.
Freud e la via regia all’inconscio
Freud parlava dei sogni come della via regia per accedere all’inconscio. In Die Traumdeutung (1899), egli distingue tra contenuto manifesto e contenuto latente: tra ciò che il sognatore ricorda e narra, e ciò che resta occulto, deformato, spostato, condensato. I meccanismi del lavoro onirico — condensazione, spostamento, simbolizzazione — sono gli artefici che trasformano il desiderio inconscio in narrazione notturna.
Il sogno, secondo Freud, ha una funzione precisa: realizzare il desiderio e insieme proteggere il sonno. È il compromesso perfetto: la coscienza dorme, l’inconscio parla. Da qui il suo valore clinico: il sogno non è una fantasia estetica, ma il luogo dove la verità psichica, repressa e proibita, trova forma accessibile.
Jung e la rivelazione simbolica
Carl Gustav Jung ruppe con il maestro, sostenendo che i sogni non mascherano ma rivelano. Non più desideri rimossi, ma archetipi universali: immagini che appartengono all’umanità intera, matrici psichiche collettive. Qui il sogno diventa un ponte tra individuo e cosmo, un messaggio esistenziale, un’eco del processo di individuazione.
La tensione tra Freud e Jung non è mero dissidio teorico: è la spaccatura tra due concezioni del sogno che ancora oggi si contendono la scena clinica.
Neuroscienze e psicologia cognitiva
La modernità ha aggiunto nuovi strumenti. Hobson e McCarley, con l’ipotesi di Attivazione-Sintesi, ridussero il sogno a prodotto casuale dell’attività neurofisiologica: una narrazione goffa creata per dare coerenza a impulsi caotici. Ma la stessa neuroscienza, qualche decennio dopo, ha corretto quella visione, riconoscendo il ruolo motivazionale e affettivo del sogno, soprattutto legato ai circuiti dopaminergici.
Parallelamente, la psicologia cognitiva ha proposto la Teoria della Simulazione delle Minacce (Revonsuo): il sogno come laboratorio evolutivo, dove la mente si addestra ad affrontare pericoli, scenari e conflitti. Un teatro protetto in cui il soggetto sperimenta strategie emotive e difensive.
Il sogno in terapia: il linguaggio che cura
Ma cosa significa tutto questo nella pratica clinica? Significa che il sogno, qualunque sia la teoria di riferimento, si offre al terapeuta come oggetto transizionale della psiche: è narrazione, immagine, residuo diurno, condensato simbolico, messaggio universale.
Il sogno è importante in terapia perché:
Rivela desideri e paure che la coscienza censura.
Permette di osservare i conflitti senza difese razionali.
Funziona come regolatore degli affetti.
Consolida la memoria emotiva.
Offre un ponte narrativo tra inconscio e parola.
Non è la “decifrazione” a fare la differenza, ma l’uso clinico. Il sogno diventa cura non perché tradotto in un codice segreto, ma perché narrato, condiviso, accolto nella relazione terapeutica.
Conclusione: l’attualità del sogno
Freud aveva ragione: il sogno resta la via regia all’inconscio. Ma oggi sappiamo che questa via non è unica né lineare. È un labirinto fatto di simboli, neurotrasmettitori, archetipi e narrazioni.
In terapia, il sogno non è un oracolo, ma un atto clinico. È ciò che accade quando l’inconscio prende parola nella notte e trova un testimone che lo sappia ascoltare senza ridurlo. È materia viva che il terapeuta e il paziente co-costruiscono, trasformando immagini mute in esperienza condivisa.
In un’epoca che tende a ridurre tutto a dati e algoritmi, i sogni ci ricordano che l’essere umano non è mai interamente calcolabile. Essi parlano con il linguaggio del desiderio e della paura, ma anche con quello della creatività e della trasformazione. Per questo, nella psicoterapia, il sogno non è accessorio: è uno degli strumenti più potenti per rivelare, comprendere e guarire.
Analisi Critica e Prospettive Integrative sull'Interpretazione dei Sogni in Ambito Psicoanalitico e Psicologico
I. Le Fondazioni Epistemologiche dell'Interpretazione Onirica
L'indagine sull'interpretazione dei sogni, pur affondando le radici nell'antichità, ha subito una profonda trasformazione epistemologica nel passaggio dalla sfera mistica a quella scientifica. Questo percorso ha stabilito le basi per lo studio psicologico e psicoanalitico del fenomeno onirico.
1.1. Contesto Storico e la Nascita della Psicologia del Sogno
Nell'antichità, la valutazione del sogno era strettamente legata alla posizione filosofica sulla mantica in generale. Il sogno, con la sua straordinaria varietà di contenuti e impressioni, rendeva difficile una concezione unitaria. Già negli scritti di Aristotele (
De divinatione per somnium e De somniis), il sogno cessava di essere considerato un messaggio diretto della divinità per diventare un oggetto della psicologia: la sua natura non era divina, ma demoniaca, e la sua valutazione dipendeva da criteri proto-psicologici.
1.2. Sigmund Freud: La Via Regia all'Inconscio
La vera rivoluzione nello studio scientifico del sogno si concretizzò con la pubblicazione de L'interpretazione dei sogni (1899) di Sigmund Freud. Quest'opera fondamentale pose il sogno non più come enigma mistico, ma come la "via regia" per accedere alla comprensione dell'inconscio.
La teoria freudiana si basa sulla distinzione tra contenuto manifesto (ciò che il sognatore ricorda e narra) e contenuto latente (i desideri inconsci repressi e i residui diurni che hanno motivato il sogno). Il contenuto latente viene trasformato in manifesto attraverso il lavoro onirico, che impiega meccanismi come la condensazione, lo spostamento e la simbolizzazione.
Freud stabilì un quadro rigorosamente causale e motivazionale del sogno. Postulò che il sogno dovesse essere, per sua natura, una realizzazione di desiderio (wish-fulfillment), argomentando che "nulla se non un desiderio può mettere in moto il nostro apparato mentale". Il desiderio è, quindi, la forza motrice necessaria per l'attività onirica. Funzionalmente, il sogno agisce come il "guardiano del sonno": quando uno stato pulsionale emerge durante la notte minacciando il risveglio, l'esperienza allucinatoria della sua soddisfazione consente al sonno di continuare.
Il meccanismo della censura fu introdotto per spiegare come i desideri inaccettabili venissero distorti e mascherati, proteggendo così il sognatore dall'ansia e permettendo al contenuto altrimenti proibito di esprimersi. Il postulato di Freud stabilisce che il sogno è intrinsecamente un prodotto della storia individuale e della repressione.
1.3. Carl Gustav Jung: L'Inconscio Collettivo e gli Archetipi
Carl Gustav Jung, pur partendo dalla psicoanalisi, si allontanò dal modello freudiano incentrato sui desideri repressi dell'inconscio personale, ampliando la ricerca all'inconscio collettivo.
Per Jung, i sogni non mascherano, ma rivelano. Essi rappresentano l'espressione simbolica degli archetipi, immagini universali e innate che risiedono in questa dimensione psichica più profonda. I sogni sono considerati un ponte verso i processi psichici che influenzano il benessere e il comportamento, e il loro lavoro è fondamentale per il
processo di individuazione. In questa prospettiva, il sogno funge da messaggio esistenziale, essenziale per la crescita e la comprensione del sé.
La distinzione tra Freud e Jung rivela una fondamentale tensione epistemologica: la psicologia del sogno è basata sulla Storia Individuale (Freud, causalità e mascheramento pulsionale) o sulla Struttura Umana Universale (Jung, rivelazione simbolica). La psicoanalisi classica postula che per interpretare il sogno (la lettura del contenuto manifesto), il clinico debba superare la censura. Tuttavia, questa necessità di lettura (decifrazione) entra in conflitto logico con l'assunto di un mascheramento perfetto da parte del "censore psichico," un conflitto che sarà centrale nelle critiche mosse dalla ricerca empirica e neuroscientifica successiva.
II. Il Sogno nell'Ottica della Psicologia Sperimentale e Quantitativa
L'esigenza di collocare lo studio dei sogni all'interno dei canoni scientifici ha guidato lo sviluppo di metodologie che mirano all'oggettivazione e alla quantificazione del contenuto onirico, fondamentali per stabilire la replicabilità e la validità della ricerca.
2.1. L'Evoluzione della Ricerca Empirica
La ricerca psicologica richiede che i metodi di analisi del sogno soddisfino criteri scientifici rigorosi, tra cui la replicabilità da parte di diversi gruppi di ricerca, la valutazione di affidabilità e validità, e la minimizzazione del bias sperimentatore. L'obiettivo è misurare in modo sistematico gli aspetti del contenuto onirico.
2.2. Il Sistema di Codifica Hall/Van de Castle (HCS)
Il sistema di codifica di Hall e Van de Castle (HCS), sviluppato negli anni '60, è riconosciuto come uno dei metodi fondamentali per l'analisi quantitativa del contenuto onirico (Dream Content Analysis). Il sistema è stato costruito per misurare in modo economico e completo vari aspetti del contenuto del sogno.
Una distinzione metodologica cruciale nell'HCS è quella tra categorie teoriche ed empiriche.
Categorie Teoriche: Sono quelle derivate da una specifica teoria della personalità (ad esempio, la teoria degli archetipi di Jung o la teoria del complesso di castrazione di Freud) e applicate al resoconto onirico. I tentativi di sviluppare scale teoriche basate su concetti psicoanalitici classici (come l'ansia di castrazione) hanno sistematicamente fallito nella replicazione, producendo risultati inaspettati o non affidabili. Ciò ha portato gli sviluppatori dell'HCS a ritenere che tali categorie, sebbene ricche di significato idiografico, non abbiano un futuro promettente nella misurazione quantitativa su vasta scala.
Categorie Empiriche: Sono state sviluppate attraverso l'osservazione e l'analisi di numerosi resoconti onirici, senza un'intenzione teorica predefinita. Esempi includono "Amici," "interazioni aggressive," "attività fisiche," e "sventure". Queste categorie si sono dimostrate più utili e affidabili.
I principi di codifica dell'HCS richiedono che tutte le categorie siano nominali (non gerarchiche, senza assegnazione di pesi o ranghi) e che i loro limiti siano definiti con precisione per garantire un'alta affidabilità tra i codificatori (intercoder reliability). Le dieci categorie generali dell'HCS coprono aspetti come Personaggi, Interazioni Sociali, Attività, Emozioni, e Ambienti Fisici.
2.3. Applicazioni Cliniche e l'Ipotesi di Continuità
L'applicazione clinica del HCS ha permesso di confrontare i resoconti onirici di pazienti con specifiche patologie (ad esempio, schizofrenia delirante) con gruppi di controllo.
Recentemente, l'uso di algoritmi di Natural Language Processing (NLP) ha permesso l'automazione dello scoring dei resoconti onirici secondo l'HCS. Tali innovazioni metodologiche hanno consentito l'analisi di un volume di dati senza precedenti (oltre 24.000 resoconti). Questa ricerca su larga scala ha fornito un supporto empirico all'
Ipotesi di Continuità, che afferma che i sogni sono una continuazione diretta e quantificabile degli eventi, delle preoccupazioni e della realtà sociale ed emotiva della vita di veglia.
Il fallimento sistematico delle categorie teoriche derivate dalla psicoanalisi classica nell'HCS, contrapposto al successo delle categorie empiriche e alla validazione dell'ipotesi di continuità , ha avuto un impatto significativo sulla psicologia del sogno. Suggerisce che i costrutti psicoanalitici tradizionali, pur potendo offrire una cornice interpretativa a livello idiografico, risultano non operazionalizzabili o misurabili oggettivamente su vasta scala. Il focus della ricerca si è quindi spostato dalla decifrazione di contenuti latenti a inferenze meno misurabili alla validazione e analisi quantitativa del contenuto manifesto e narrativo.
III. Modelli Neuroscientifici e Cognitivi della Formazione e Funzione del Sogno
A partire dalla scoperta del sonno REM e dall'avanzamento delle tecniche di brain imaging, la neuroscienza ha offerto un paradigma radicalmente differente per comprendere la genesi e la funzione dei sogni, ponendosi inizialmente in netto contrasto con le teorie psicodinamiche.
3.1. Il Quadro Neurobiologico: REM e NREM
I metodi avanzati di misurazione hanno permesso di quantificare obiettivamente i tre principali stati cerebrali: veglia, sonno NREM e sonno REM. Il sonno REM è caratterizzato da una riattivazione globale del cervello, spesso superiore al grado di attivazione osservato durante la veglia. Studi hanno dimostrato che i sogni REM sono prevalentemente carichi affettivamente e dominati dalle immagini, distinguendosi dall'attività mentale NREM.
Fisiologicamente, durante il sonno REM si verifica l'attivazione di una rete ascendente, accompagnata dall'inibizione delle afferenze sensoriali a livello del tronco encefalico.
3.2. L'Hypothesis di Attivazione-Sintesi (A-S) di Hobson e McCarley
La Activation-Synthesis Hypothesis (A-S), proposta da J. Allan Hobson e Robert McCarley nel 1977, ha rappresentato la sfida più diretta alla teoria freudiana. Questa teoria neurobiologica postula che i sogni siano il risultato dell'attivazione automatica e periodica del tronco encefalico, in particolare attraverso segnali ponto-geniculo-occipitali (PGO).
Secondo l'ipotesi A-S, il proencefalo tenta di sintetizzare una narrazione coerente (il contenuto manifesto) per dare senso ai segnali caotici e ai cambiamenti biochimici (come gli intensi e sporadici impulsi sensoriali e motori) che si originano nel tronco encefalico. Il sogno è descritto come una "narrazione maldestra" creata per conferire coerenza a un input fondamentalmente casuale.
Hobson ha storicamente utilizzato questa teoria come polemica contro Freud, sostenendo che l'influenza psicoanalitica avesse ostacolato il progresso scientifico nello studio dei sogni. Egli ha rifiutato l'idea che i sogni contengano messaggi nascosti dalla censura, spiegando la bizzarria onirica non come un mascheramento elaborato, ma come la conseguenza della perdita della capacità organizzativa del cervello durante il REM. L'ipotesi A-S si è evoluta nel modello AIM (
Activation, Input-output gating, Modulation), che introduce il concetto di protocoscienza per descrivere i diversi stati cerebrali.
3.3. Il Dibattito Critico: Motivazione e Neuropsicoanalisi
Nonostante la dichiarata vittoria su Freud e la presentazione iniziale dei sogni come motivationalmente neutrali, la posizione di Hobson ha subito un'evoluzione.
Il neuroscienziato ha successivamente fatto la "franca concessione" che "il gioco sfrenato della dopamina nel sonno REM è in linea con l'assunto che il sognare sia 'motivato'". Questa rettifica è di fondamentale importanza, poiché il sistema dopaminergico mesocortical-mesolimbico è intrinsecamente collegato agli stati motivazionali, all'esplorazione e al comportamento orientato all'obiettivo.
In questo senso, l'evidenza neurobiologica, pur demolendo la tecnica freudiana della censura e del mascheramento come meccanismo primario, tende a riabilitare il suo postulato fondamentale sulla natura affettiva e pulsionale del sogno. La neuropsicoanalisi, in particolare attraverso il lavoro di Solms (il Reward Activation Model), sostiene che il circuito dopaminergico è il motore primario del sogno e che l'esperienza onirica ha la funzione di simulare e testare soluzioni adattive a problemi. La convergenza tra Hobson e Freud sulla natura motivata del sogno è un punto di svolta nel dibattito teorico.
3.4. Modelli Funzionali Cognitivi
In parallelo allo sviluppo neuroscientifico, la psicologia cognitiva ha esplorato le funzioni adattive del sogno, collocando il fenomeno in un continuum con l'esperienza di veglia.
Un modello significativo è la Teoria della Simulazione delle Minacce (TST), che propone che il funzionamento cerebrale durante il sonno sia un prodotto evolutivo. Il sogno simulerebbe minacce e pericoli, permettendo al sognatore di allenare strategie di difesa e adattamento, nonché di esercitarsi nella gestione delle emozioni spiacevoli.
Questa prospettiva evidenzia il ruolo cruciale del sonno REM nell'elaborazione delle esperienze di veglia emotivamente significative, contribuendo al consolidamento della memoria emotiva attraverso una rielaborazione creativa. Inoltre, i sogni possono avere una funzione sociale, stimolando la capacità empatica e simulando la realtà interpersonale. Alcuni sogni sono anche visti come esperienze coscienti ricche e diversificate, sebbene con un grado variabile di comprensione riflessiva (ad eccezione del sogno lucido).
L'analisi funzionalista del sogno (come la TST e il ruolo nell'elaborazione emotiva) fornisce una spiegazione adattiva che mancava nella psicoanalisi classica. Se il sogno è primariamente un regolatore degli affetti e un organizzatore dell'esperienza, questo stabilisce un terreno comune tra la ricerca cognitiva e la psicoanalisi contemporanea (come verrà discusso nel IV Capitolo), focalizzata sul sogno come regolatore degli affetti.
Per visualizzare il contrasto tra i modelli eziologici:
Tabella 1: Confronto tra i Principali Modelli Teorici del Sogno
Modello | Autore Chiave | Causa Principale del Sogno | Funzione Primaria (Secondo il Modello) | Stato del Contenuto Manifesto |
Psicoanalisi Classica | S. Freud | Realizzazione di un desiderio represso | Guardiano del sonno | Mascheramento del contenuto latente (Censura) |
Psicologia Analitica | C.G. Jung | Espressione di forze archetipiche | Processo di Individuazione | Rivelazione simbolica, non mascheramento |
Activation-Synthesis | J.A. Hobson | Attivazione casuale del tronco encefalico (PGO) | Epifenomeno neurale (inizialmente); Protocoscienza | Narrazione confusa creata dal proencefalo |
Simulazione Minacce | A. Revonsuo | Prodotto dell'evoluzione | Addestramento a strategie di difesa/adattamento | Simulazione diretta di pericoli emotivi/sociali |
IV. Evoluzioni Contemporanee della Psicoanalisi e Psicologia Dinamica
In risposta alle sfide metodologiche (HCS) e alle scoperte neuroscientifiche (A-S e dopamina), la modellistica psicoanalitica ha subito ampie revisioni, allontanandosi dal rigido determinismo pulsionale freudiano per integrare prospettive relazionali e intersoggettive.
4.1. Revisioni Psicoanalitiche Post-Freudiane e il Ruolo del Non-Pensato
La psicoanalisi contemporanea ha riconosciuto la complessità del processo onirico, notando come spesso il sognato non sia una storia o un racconto coerente. Anche quando presente, il racconto onirico possiede una sua "logica" distinta da quella dello stato di veglia e può riguardare pensieri e immagini attinenti a temi attuali del sognatore.
Gli sviluppi post-freudiani, in particolare quelli legati a Bion e alla Klein, hanno introdotto il concetto di esperienza non pensata o "sogni-non-sognati". Questo implica che l'analista deve impegnarsi in un processo di "mesomerizzazione" o
at-one-ment, sognando—sia nel sonno che nella veglia della seduta analitica—quegli stati emotivi che il paziente non è riuscito a contenere o simbolizzare. Questo compito è ontogenicamente affidato alle matrici simboliche originali, spesso connesse all'ambiente materno/paterno.
4.2. La Prospettiva Intersoggettiva e Relazionale
La revisione del modello teorico e tecnico freudiano ha portato a una forte enfasi sulla dimensione interpersonale del sogno, superando l'analisi strettamente intrapsichica. La psicoanalisi contemporanea utilizza il sogno non solo come espressione dell'inconscio individuale, ma come un fenomeno co-costruito all'interno della relazione terapeutica.
Questo approccio si articola attraverso un triplice vertice di lettura :
Il Sogno Sognato: Riguarda l'espressione del funzionamento neurofisiologico.
Il Sogno Ricordato: Riferito al modo in cui il sognatore traduce in parole la propria esperienza onirica.
Il Sogno Narrato/Co-Costruito: Il racconto condiviso in seduta, che viene compreso all'interno della relazione terapeutica, diventando un fenomeno intersoggettivo ed esperienziale.
C'è una rinnovata attenzione per l'aspetto manifesto dei sogni: le immagini e le narrazioni sono considerate valide di per sé, in quanto modelli organizzatori dell'informazione e regolatori degli affetti. Questa funzione è in linea con le scoperte della ricerca neuroscientifica e cognitiva sul ruolo del sogno nell'elaborazione emotiva e nel consolidamento della memoria. Il significato non risiede più esclusivamente in un messaggio cifrato (contenuto latente), ma emerge dall'interazione emotiva e narrativa con il terapeuta, che funge da "terzo analitico intersoggettivo".
Il passaggio dal contenuto latente individuale (Freud) al "sogno narrato" riflette una svolta relazionale più ampia. Il processo interpretativo si trasforma da pura decifrazione a comprensione esperienziale e condivisa. La funzione primaria del sogno, nella clinica dinamica contemporanea, viene ridefinita in termini di regolazione degli affetti e organizzazione dell'esperienza, integrando di fatto le scoperte funzionaliste della psicologia cognitiva.
Tabella 2: L'Evoluzione dell'Interpretazione del Sogno nella Clinica Contemporanea (Vertici di Lettura)
Vertice di Analisi | Definizione e Focus | Dimensione Prevalente | Implicazione Clinica Primaria |
Sogno Sognato | Espressione del funzionamento neurofisiologico | Intrapsichica non verbale | Comprensione dei processi neurocognitivi e regolazione degli affetti |
Sogno Ricordato | Modalità con cui il sognatore mette in parola l'esperienza onirica | Intrapsichica e Narrativa | Analisi degli schemi cognitivi e del modo di narrare il Sé |
Sogno Narrato/Intersoggettivo | Racconto condiviso che viene compreso nella relazione terapeutica | Intersoggettiva e Relazionale | Strumento di co-costruzione di significato e fenomeno relazionale |
V. L'Utilizzo Clinico Differenziato e Integrato del Materiale Onirico
Il sogno è universalmente riconosciuto come una risorsa preziosa per l'indagine clinica. L'evoluzione teorica e l'integrazione con le neuroscienze hanno permesso a diverse scuole di pensiero di sviluppare metodologie specifiche per l'utilizzo del materiale onirico.
5.1. Il Lavoro sul Sogno nelle Terapie Psico-Dinamiche
Nelle direttive cliniche attuali, l'analista è liberato dalla "gravosa e scoraggiante ricerca del significato latente". La variabilità dell'attività mentale onirica è riconosciuta. Il lavoro si concentra sulla comprensione dinamica del sogno all'interno della relazione, valorizzando l'intersezione delle dimensioni intrapsichiche e interpersonali.
5.2. L'Approccio Umanistico ed Esistenziale
Psicologia Analitica Archetipica (Jungiana)
La psicoterapia analitico-archetipica continua a considerare i sogni come un ponte essenziale verso l'inconscio, dove l'espressione simbolica degli archetipi è fondamentale per esplorare i processi psichici profondi e raggiungere l'equilibrio interiore.
Terapia della Gestalt
Nella Terapia della Gestalt, il sogno è interpretato come un messaggio esistenziale. Sebbene il sogno sia ricco di simboli e metafore (universali, culturali o strettamente personali) , il lavoro clinico non mira alla decifrazione, ma alla riappropriazione. Ogni elemento, personaggio, o stato d'animo nel sogno è visto come una parte integrante e, spesso, frazionata del Sé del paziente. Raccontare il sogno permette al paziente di comunicare direttamente pensieri e sentimenti altrimenti trattenuti, favorendo l'integrazione.
5.3. Integrazione nelle Terapie Cognitivo-Comportamentali (CBT)
Storicamente, la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) ha mantenuto una posizione critica sull'uso dei sogni, principalmente a causa della mancanza di dati sperimentali e modelli di intervento replicabili coerenti con le scienze cognitive. Tuttavia, negli ultimi 25 anni, i dati della ricerca clinica e delle neuroscienze cognitive hanno supportato la necessità di utilizzare il materiale onirico, inserendone le funzioni in un
continuum con la veglia.
Le evidenze accumulate supportano l'esigenza per i terapeuti CBT di saper impiegare il materiale onirico portato dai pazienti, spesso attraverso tecniche modulari e replicabili (come il modello DMR ), che consentono di analizzare e ristrutturare gli schemi cognitivi e di lavorare sull'elaborazione emotiva e il consolidamento della memoria, in linea con le scoperte sul sonno REM. Il valore clinico del sogno in queste terapie non dipende dalla validità dell'eziologia freudiana o neurobiologica, ma dalla sua utilità pragmatica come stimolo narrativo e veicolo per il lavoro sui processi cognitivi e affettivi.
5.4. Conclusioni e Prospettive Future: Verso un Modello Integrato del Sogno
L'analisi della ricerca psicologica e psicoanalitica sull'interpretazione dei sogni nel XXI secolo rivela un notevole spostamento paradigmatico e una significativa convergenza interdisciplinare.
Il punto di accordo cruciale tra psicoanalisi contemporanea, cognitivismo e neuroscienze risiede nel riconoscimento del sogno come un potente regolatore degli affetti e un organizzatore dell'esperienza, superando l'ossessiva ricerca del significato latente e valorizzando il contenuto manifesto e la narrazione.
La tendenza è verso un pragmatismo clinico: indipendentemente dalla teoria eziologica (desideri repressi, archetipi, o attivazioni cerebrali casuali), la funzione terapeutica primaria del sogno si manifesta nella sua capacità di agire come un catalizzatore relazionale. L'atto di condividere e co-costruire il significato del "sogno narrato" permette all'ambiente terapeutico (il clinico) di fornire la funzione di contenimento e simbolizzazione per quei processi di elaborazione neurocognitiva ed emotiva che il sognatore non è riuscito a completare internamente.
In definitiva, sebbene Freud, Jung e le neuroscienze offrano "tre chiavi diverse" per accedere a questa parte misteriosa della mente, tutte le prospettive concordano sul fatto che i sogni parlano e guidano, aiutando l'individuo a comprendere meglio sé stesso. Il futuro della ricerca risiede nell'integrazione di queste prospettive, al fine di sviluppare una comprensione più complessa e consapevole del fenomeno onirico.
Fonti usate nel report




Comments