La gelosia nella coppia: tra ombra psichica e desiderio d’amore
- Daniele Russo
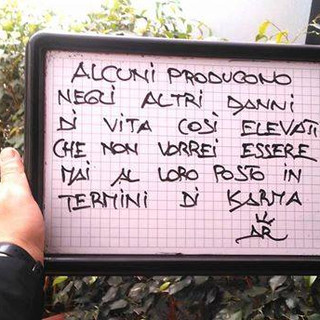
- 18 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
“La gelosia è il drago che uccide l'amore sotto il pretesto di tenerlo al sicuro.”— Havelock Ellis

In ogni amore profondo c’è una parte d’ombra. La gelosia — parola densa, aspra e spesso negata — si presenta come guardiana feroce del legame, ma ne rivela al contempo la fragilità strutturale. Essa attraversa il tempo, le culture, le differenze di genere, assumendo forme che variano dall’eco sommessa di un’inquietudine alla furia cieca del sospetto paranoide.
Come psicologo clinico esperto in dinamiche di coppia, ho incontrato la gelosia nelle sue maschere più disparate. Ma è solo entrando in profondità che si può svelare ciò che essa nasconde: il bisogno disperato di sentirsi visti, scelti, preferiti — in ultima analisi, amati.
L’anatomia della gelosia: tra teoria dell’attaccamento e pulsione di possesso
La letteratura psicologica più solida ci offre molteplici lenti per osservare il fenomeno. Secondo John Bowlby, padre della teoria dell’attaccamento, la gelosia si origina da modelli interni insicuri: chi ha vissuto relazioni primarie instabili o discontinue tende, in età adulta, a percepire ogni minaccia come una conferma dell’abbandono atteso (Bowlby, 1988). In questo senso, la gelosia non è un’emozione “immatura”, ma una risposta antica alla paura della perdita.
David Buss, invece, tra i maggiori esponenti della psicologia evoluzionistica, ha mostrato come la gelosia abbia un fondamento adattivo: negli uomini, essa si attiverebbe prevalentemente di fronte al sospetto di un tradimento sessuale (a rischio di paternità non certa); nelle donne, al timore di una deviazione affettiva (e quindi della perdita di risorse e protezione) (Buss et al., 1992).
Nel lavoro clinico, tuttavia, queste spiegazioni teoriche si intrecciano con le trame soggettive più complesse. La gelosia, infatti, non è solo una questione di biologia o memoria infantile: è anche linguaggio relazionale, tentativo disfunzionale di comunicare la propria fame d’amore.
Casi clinici: il volto umano della gelosia
Laura e Michele, 42 e 45 anni, si presentano in terapia dopo un episodio in cui lei ha frugato nel telefono di lui e ha scoperto messaggi affettuosi a una collega. Michele nega qualsiasi coinvolgimento fisico, ma Laura è distrutta. Lavorando insieme, emerge un pattern costante: lei ha sempre avuto la sensazione di essere una “seconda scelta”; lui, a sua volta, vive ogni richiesta di rassicurazione come un attacco. Il conflitto sulla gelosia diventa allora un dramma simbolico in cui ciascuno recita un copione antico: quello di chi chiede troppo e quello di chi si ritrae.
Nel percorso terapeutico, abbiamo esplorato non solo il comportamento (controllo, accuse, ritiro), ma soprattutto le emozioni sottostanti: paura, senso d’inadeguatezza, rabbia e bisogno di riconoscimento. Solo riconoscendo la vulnerabilità reciproca, la coppia ha potuto iniziare a trasformare la gelosia in un’occasione di intimità più autentica.
Forme di gelosia: normale, patologica, proiettiva
Non tutta la gelosia è patologica. Nelle prime fasi dell’amore, una lieve inquietudine può essere persino salutare, segno che si attribuisce valore all’altro e si teme di perderlo. Ma quando la gelosia invade ogni scambio, deteriora la fiducia e si trasforma in controllo, essa diventa sintomo.
In ambito psicodinamico, la gelosia viene talvolta interpretata come proiezione del proprio desiderio infedele sull’altro. Freud (1910), in un saggio poco citato ma acuto, distingue tre livelli di gelosia: normale, proiettiva e delirante. Nella forma delirante — oggi riconducibile ai disturbi paranoidei o borderline — il soggetto è prigioniero di una convinzione assoluta e non correggibile.
Dal punto di vista sistemico-relazionale, la gelosia viene invece letta come un sintomo del legame, spesso mantenuto da regole implicite e copioni familiari: ad esempio, in alcune famiglie d’origine il controllo sull’altro è stato confuso con l’amore. La gelosia può così essere “ereditaria”, appresa e reiterata.
Digitale e gelosia: una nuova era della minaccia amorosa
La contemporaneità ha offerto nuove armi all’antico mostro. Oggi, la gelosia si insinua nei like di Instagram, nei “visualizzato ma non risposto”, nei profili attivi su Tinder anche dopo l’inizio di una relazione.
Una ricerca condotta da Elphinston e Noller (2011) ha coniato il termine Facebook jealousy, mostrando come l’uso ossessivo dei social media amplifichi la gelosia retroattiva e la percezione di minaccia. I partner spesso si ritrovano a indagare il passato digitale dell’altro, alla ricerca di indizi, confronti e conferme delle proprie paure.
Come terapeuta, ho spesso visto come la gelosia digitale sia sintomo di un’insicurezza relazionale profonda, e al tempo stesso una minaccia concreta alla costruzione della fiducia.
Verso un’elaborazione possibile: dal controllo al contatto emotivo
Non si cura la gelosia con la razionalità. Frasi come “non hai motivo di essere geloso/a” spesso non fanno che aggravare il problema. La gelosia non risponde alla logica, ma al bisogno profondo di sentirsi importanti per l’altro.
Nel lavoro terapeutico, i passaggi fondamentali sono:
Riconoscere la gelosia senza colpevolizzarla, come emozione segnale;
Indagare la sua origine psichica, attraverso la storia personale del paziente;
Ridefinire i confini della coppia, promuovendo comunicazione e sicurezza;
Trasformare la gelosia in vulnerabilità condivisa, ovvero possibilità di chiedere, dire, mostrarsi.
Come affermava Nietzsche:
“Nella gelosia c’è più amor proprio che amore.”Ma spesso, proprio partendo dall’amor proprio ferito, si può rinascere a una forma d’amore più matura.
Conclusione: gelosia come possibilità
La gelosia, se compresa e affrontata con lucidità e coraggio, può diventare una soglia: un passaggio tra l’amore idealizzato e quello reale. Essa ci costringe a interrogarci sui nostri desideri, le nostre paure, il modo in cui chiediamo amore. Come ogni sintomo, è una lingua: spetta alla coppia — accompagnata da una guida competente — imparare a tradurla.
Perché non esiste coppia senza conflitto, ma solo coppie che imparano a trasformare il conflitto in comprensione.
Bibliografia essenziale
Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development.
Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science, 3(4), 251–255.
Freud, S. (1910). Psychoanalytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides).
Elphinston, R. A., & Noller, P. (2011). Time to face it! Facebook intrusion and the implications for romantic jealousy and relationship satisfaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 631-635.






Commenti